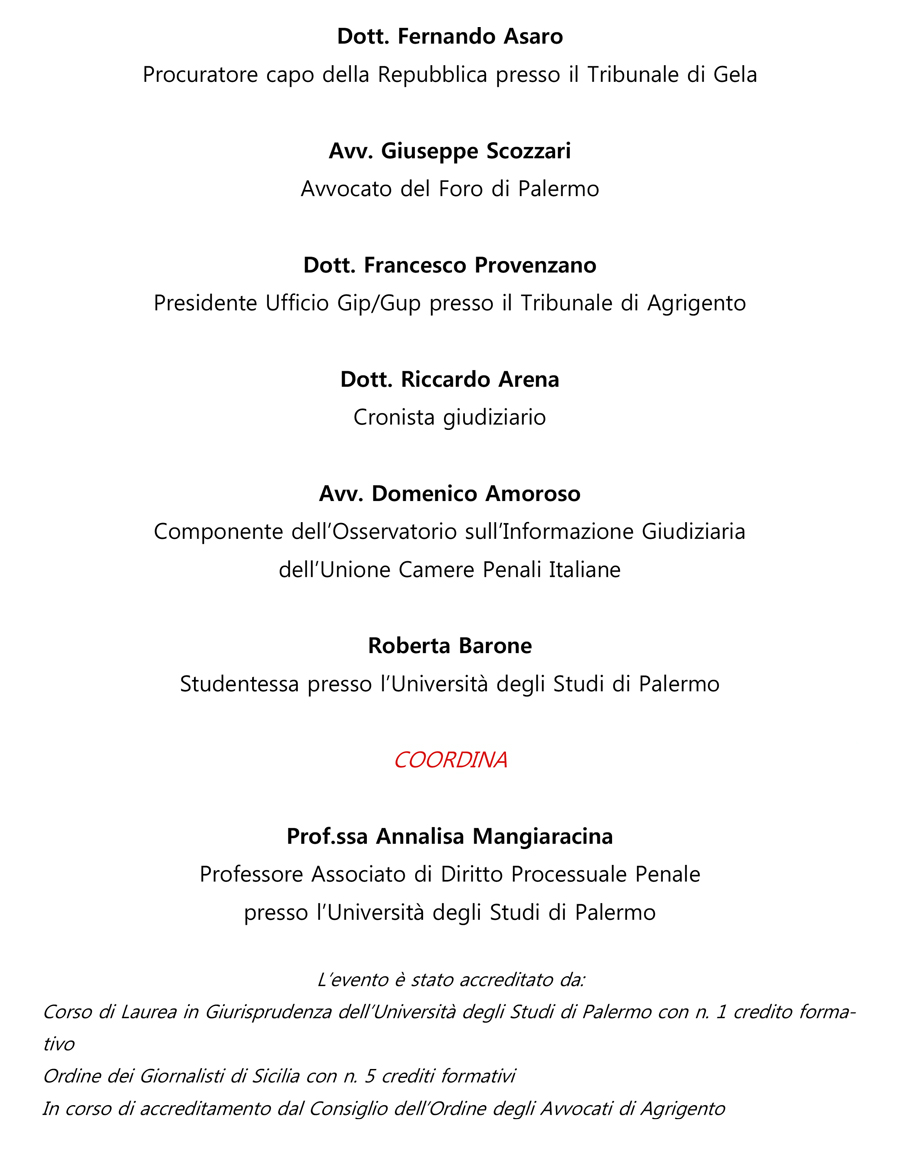Diritto Civile: Il risarcimento del danno anche alle coppie di fatto che non coabitano. (Cass. Civ. Sez. III n. 9178/2018)
Con l’espressione “famiglia di fatto” si identifica quella relazione sorta dalla semplice convivenza personale tra un uomo e una donna, in assenza di un vincolo matrimoniale.
Forma di aggregazione sociale che ha progressivamente assunto dimensioni davvero consistenti, inducendo da un lato il legislatore ad introdurre un’apposita regolamentazione dell’istituto e, parimenti, dall’altro lato un’intensa elaborazione giurisprudenziale, corroborata dai contributi della più moderna dottrina.
Pur non essendo invocabile l’art. 29 Cost. che fa espresso riferimento alla “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, la famiglia di fatto ha ricevuto tutela costituzionale quale “formazione sociale” nella quale si estrinseca la personalità dell’individuo (ai sensi dell’art. 2 Cost.).
Con la legge n. 76 del 2016 (cosiddetta “Legge Cirinnà”) vengono per la prima vota introdotte e disciplinate nell’ordinamento italiano le convivenze di fatto (commi 36 e ss.).
In particolare per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente (anche senza registrazione della coppia all’anagrafe del Comune di residenza) da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, tra le quali non intercorrono rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (comma 36 l. n. 76/2016).
Analizzando il caso del decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49 l. n. 76/2016).
In tal modo il legislatore ha posto fine al dibattito sviluppatosi in passato sul punto.
Dibattito in cui anche la giurisprudenza, solo di recente, ha ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) sulla base della considerazione che anche la perdita del convivente more uxorio determina nell’altro soggetto una sofferenza analoga a quella che si ingenera nell’ambito della famiglia (matrimoniale), purché si dia prova della tendenziale stabilità e della consistente durata del rapporto.
Su tali basi normative e giurisprudenziali la Corte di Cassazione, tenendo conto anche dei tempi moderni e delle difficoltà economiche, ha recentemente riconosciuto la risarcibilità del convivente superstite anche in mancanza di una prova certa della convivenza, ponendo l’attenzione sullo “stabile rapporto affettivo fra i conviventi” corroborato da indizi che devono essere valutati in maniera unitaria e non frazionata (Cass. Civ. Sez. III n. 9178/2018).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una signora alla quale l’assicurazione aveva negato il diritto al risarcimento per la morte del compagno. In particolare il Giudice di merito adito aveva riconosciuto la relazione e la frequentazione regolare tra la coppia, tuttavia mancava la prova della convivenza, anzi risultava che il compagno aveva la residenza in un altro Comune.
La Corte di Cassazione, nel decidere sulla questione, ha fondato la propria decisione tenendo conto della situazione attuale con particolare riferimento alla crisi economica del Paese, che obbliga una coppia a vivere in case e Comuni diversi e distanti, senza però alterare il rapporto affettivo fra la coppia.
In aggiunta a tale ragionamento, nel caso erano presenti degli “indizi” sulla convivenza della coppia quali: un conto in comune, la scelta dello stesso medico di base, la presenza delle agende del compagno in casa della signora; tuttavia, alla luce di tali indizi il Giudice di merito, errando, non ha considerato l’unitarietà di queste circostanze, che comprovavano un rapporto affettivo stabile e ben consolidato tra la coppia.
Dott. Biagio Cimò
ContinuaDiritto Penale: L’istituto della messa alla prova dei minori posto all’attenzione dei giudici della Corte costituzionale. Se l’esito non è positivo nessuna riduzione di pena prevista.
E’ finito sotto la lente giurisprudenziale della Consulta una vicenda che vede un minore imputato del reato di concorso in ricettazione sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.
La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sull’applicazione estensiva dell’articolo 657- bis del codice di procedura penale (computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca) nei confronti del minore.
L’articolo suddetto prevede che il pubblico ministero, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, nel determinare la pena da eseguire, possa detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita (3 giorni di messa alla prova corrispondono ad un giorno di detenzione). Nel caso in esame tale computo è stato negato e per questo motivo il difensore del minore ha invocato l’applicazione estensiva dell’articolo 657- bis del codice di procedura penale chiedendo di detrarre il periodo di “messa alla prova” dalla pena.
Il Procuratore del Tribunale per i minorenni ha rigettato la richiesta sostenendo l’impossibilità di estendere nei confronti di un minore l’applicazione di una norma prevista soltanto per gli imputati non minori, a sostegno di tale tesi ha invocato la diversità degli istituti di “messa alla prova” e di detenzione, uno rieducativo e l’altro prettamente afflittivo. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale e con l’ordinanza del 12 aprile n. 16358, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando che l’articolo 657 del codice di procedura penale in primis e l’articolo 29 del d.p.r. 448/1988 in secundis, escludono per i minori sottoposti alla “messa alla prova” la riduzione della pena in virtù del tempo trascorso sotto il regime della misura alternativa medesima. La Cassazione ha sottolineato di dover considerare la “messa alla prova” nei confronti dei minori come una pena afflittiva, poiché l’obbligo a restare all’interno di una struttura implica una limitazione della libertà di movimento. La mancata applicazione estensiva dell’articolo 657- bis del c.p.p. costituirebbe una evidente violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Costituzione che prevede si riconosca, in tali situazioni giuridiche, un trattamento eguale per tutti i soggetti soprattutto se minori. Il nostro ordinamento penale inoltre, coerentemente coi principi della Costituzione, pretende che il trattamento di tutti gli individui sia in melius e non in peius da un punto di vista sia sostanziale che processuale. La Corte costituzionale dovrà decidere se tale differenziato trattamento possa considerarsi fedele ai principi dettati dalla Carta costituzionale.
Dott.ssa Anna Maria Signorino Gelo
ContinuaDiritto Penale: Corrompere un arbitro non è reato: lo ha chiarito il decreto di archiviazione n. 28512/17 emesso dalla sezione Gip del Tribunale di Milano.
Il Gip del Tribunale di Milano, prendendo le mosse dal disposto di cui al secondo comma dell’art. 813 c.p.c., il quale prevede che «agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio», ha chiarito che all’arbitro non possono essere contestati i reati di corruzione e di corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318 e ss. c.p..
Ed infatti, il percorso argomentativo seguito dal Gip milanese, con il decreto di archiviazione n. 28512/2017, ha preso atto della tesi espressa dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 6734/2014, la quale affermato la natura privatistica del rapporto che lega l’arbitro con le parti private riconducendola, in particolare, all’istituto del mandato.
Il Gip milanese ha, peraltro, sottolineato la progressiva equiparazione degli effetti del lodo arbitrale con quelli della sentenza, testimoniata anche dalle riforme del codice del rito civile del 2014 volte allo smaltimento del contenzioso arretrato, le quali hanno previsto la possibilità di devolvere ai collegi arbitrali le controversie giacenti.
Dott. Gaspare Tesè
ContinuaPUBBLICATO IN GAZZETTA IL GLOSSARIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PER I QUALI NON È NECESSARIO ALCUN TITOLO ABILITATIVO.
Il 7 aprile 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 81 del 2 marzo 2018 al quale è stato allegato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività ad edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ovvero quelle attività per le quali non è necessario un titolo abilitativo.
Il decreto che entrerà in vigore il 22 aprile c.a., è volto ad uniformare a livello nazionale la disciplina in materia di edilizia alla quale veniva data un’interpretazione differenziata da parte dei Comuni e delle Regioni ed inoltre ad aiutare il cittadino e gli operatori a fare chiarezza in merito agli interventi che richiedano o meno un provvedimento amministrativo autorizzativo.
La lista delle 58 opere contenute nel glossario saranno soggette al regime di edilizia libera e come tali potranno essere realizzate senza alcun titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Pur tuttavia, è necessario che tali opere siano realizzate sempre nel rispetto delle prescrizioni e degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia con particolare riferimento alle norme antisismiche, di tutela del rischio idrogeologico, di quelle relative all’efficienza energetica ecc..
In concreto, la tabella riporta un elenco di 12 categorie di interventi quali quelli di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, movimenti di terra, pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, manufatti leggeri in strutture ricettive, aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di arredo delle pertinenze e così via.
In particolare, all’interno del glossario per ciascuna categoria di intervento sono elencate le principali opere ed elementi che saranno sicuramente annoverati tra gli interventi ad edilizia libera.
Tra gli interventi di edilizia libera vengono annoverati alcune categorie di interventi, per i quali in passato erano sorti, di frequente, numerose contestazioni, come ad esempio i berbecue in muratura, muretti, fontane, ricoveri per animali domestici e da cortile e così via che vengono ricomprese nella categoria delle “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”.
In conclusione, il glossario sarà un utilissimo strumento per il cittadino e tutti gli operatori per fare chiarezza e dare certezza alla materia edilizia che molto spesso è caratterizzata da una normazione astrusa, incompleta e frastagliata.
Dott. Gaspare Tesè
Continua
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI LAVORO. LA PROVA DELLA DELEGA DEVE ESSERE DATA DAL DATORE DI LAVORO. NON NECESSARIO ALCUN FORMALISMO
CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, 28 MARZO 2018, N. 14352
La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza numero 14352 del 28 marzo 2018, ha ribadito che l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell’igiene del lavoro devono fondarsi, non sulla qualifica rivestita dal soggetto, bensì sulle funzioni concretamente svolte. Inoltre, la Corte ha affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti. Ma, come asserito da costante giurisprudenza, la delega che trasferisce le funzioni dal datore di lavoro ad altri soggetti deve avvenire attraverso un atto traslativo, che sia contraddistinto dai requisiti della chiarezza e della certezza. La sentenza afferma che tali requisiti “possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né ad substantiam né ad probationem”. Nell’ambito del processo penale, quindi, la prova dell’esistenza della delega grava su chi la invoca, indipendentemente dall’esistenza dell’atto formale di delega.
Dott.ssa Roberta Mossuto
LA PRESENZA IN BILANCIO DI UN CREDITO INESIGIBILE NON SVALUTATO INTEGRA LA FATTISPECIE AGGRAVATA DEL REATO DI BANCAROTTA IMPROPRIA DA FALSO IN BILANCIO.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza decisa il 9 maggio 2017 n. 29885 ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio l’aver inserito, coscientemente, nei documenti contabili di una società, un credito inesigibile.
La sentenza in commento riguarda l’esame, da parte dei giudici della Suprema Corte, del ricorso di un amministratore di società avverso la sentenza dei giudici di prime cure per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da falso in bilancio e bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della società non richiedendo il fallimento. Di notevole rilevanza è stata la disamina in merito al reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, rappresentato dall’aver inserito nel bilancio della società un credito inesigibile dal 2007, senza aver preventivamente proceduto alla svalutazione, di almeno il 90% di esso, secondo i principi contabili. Permettendo, in questo modo, alla società di proseguire la propria attività, nonostante la stessa avesse un patrimonio netto negativo, e pertanto sarebbe dovuta essere posta in liquidazione sin dal 2007, visto e considerato che il socio non ha mai espresso la volontà di procedere ad una ricapitalizzazione della società. Tutto ciò in beffa di altri soci, creditori e terzi che dal 2007 hanno intrattenuto rapporti commerciali e contrattuali con la società che apparentemente presentava un bilancio in attivo, quando in realtà si trovava in passivo, per via della mancata svalutazione del credito inesigibile, così come previsto dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Con il ricorso, l’amministratore della società lamentava il difetto di motivazione della sentenza della Corte d’Appello ed in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio lamentava l’applicazione dei principi contabili alla fattispecie de qua, i quali a parere del ricorrente non avevano un rango tale da poter integrare la norma penale ovvero l’art. 223 della legge fallimentare.
L’art. 223 della legge fallimentare al secondo comma, numero 1 disciplina l’ipotesi della c.d. bancarotta fraudolenta impropria la quale, per la determinazione della pena, rimanda all’art. 216, primo comma della legge fallimentare, relativa alla bancarotta fraudolenta. Pertanto, ai sensi dell’art. 223 L.F., viene applicata la pena prevista per il reato di bancarotta fraudolenta, a quei soggetti che hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società ponendo in essere alcune condotte tipizzate dal legislatore nel codice civile cui la norma fa rinvio e in particolare per il caso che qui ci occupa all’art. 2621 c.c. relativamente alle false comunicazioni sociali.
Con la sentenza n. 29885 del 2017, per l’ennesima volta dall’entrata in vigore della riforma del 2002, i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul tema del delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio ed in particolare sulla rilevanza dei principi contabili, che avrebbero comportato la svalutazione di almeno il 90% del credito iscritto a bilancio in realtà inesigibile.
La statuizione della Quinta Sezione si è resa necessaria, da un lato, per dare un’interpretazione chiara ed univoca alla normativa fallimentare riformata dal legislatore del 2002 e, da ultimo anche, del 2015, ed in particolare, nel caso in esame, al disposto dell’art. 223 della legge fallimentare. Dall’altro per definire un uniforme orientamento all’ondivaga giurisprudenza della Suprema Corte, a cui si è assistiti all’indomani della riforma della legge fallimentare del 2002.
Infatti, dopo la riforma operata dal D.lgs. n. 61 del 2002, in particolare in merito alla portata dell’art. 223 della legge fallimentare, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate se la nuova formulazione dell’art. 223, secondo comma, numero 1 della legge fallimentare costituisca una semplice modifica legislativa ovvero comporti un’abolizione della precedente disciplina. Analoga questione è venuta a crearsi a seguito della modifica dell’art. 2621 c.c., cui rimanda l’art. 223 comma secondo, n. 1 della legge fallimentare, ad opera della legge n. 69 del 2015 che ha eliminato dall’art. 2621 c.c. l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”. Ebbene, dopo il suddetto intervento riformatore del 2015, come ormai spesso accade poco chiaro, si sono affermati due orientamenti giurisprudenziali: un primo orientamento in base al quale l’intervento modificativo abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo ed un secondo orientamento in base al quale la sopra richiamata modifica legislativa non abbia comportato tale effetto abrogativo e pertanto ritenendo ancora penalmente rilevante il c.d. falso valutativo.
Gli Ermellini nella sentenza in commento, sul tema della sussistenza del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, hanno sottolineato che i principi contabili sono rilevanti ed idonei ad integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 223 comma secondo n. 1 della legge fallimentare ovvero il c.d. falso valutativo. Adducendo altresì a motivazione che i principi contabili sono dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta lettura delle voci di bilancio. I Giudici di Piazza Cavour hanno, quindi, rigettato le argomentazioni della difesa che riteneva i principi contabili irrilevanti e inidonei ad integrare la norma penale e conseguentemente di quel orientamento giurisprudenziale che riteneva abrogato la fattispecie del c.d. falso valutativo.
Invero, come dimostra il richiamo operato dai Giudici in sentenza di una precedente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ovvero la n. 22474 del 31.03.2016 sembra chiarire e cristallizzare l’orientamento giurisprudenziale prediletto, ovvero quello in base al quale si considera sussistente il reato di false comunicazioni sociali rappresentate anche da elementi valutativi generalmente accettati, come i principi contabili, dai quali è possibile discostarsi fornendo un’adeguata informazione e giustificazione onde evitare di indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni.
In realtà, secondo i Giudici della Suprema Corte la condotta del soggetto agente nella fattispecie de qua era proprio quella qualificata ai sensi dell’art. 223, comma secondo n. 1 della legge fallimentare e del richiamato art. 2621 c.c. che viene rappresentata dal cosciente inserimento nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, destinate ai soci o a terzi, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti, così da indurre soci e terzi in errore o in modo tale da causare o aggravare ulteriormente il dissesto finanziario della società con l’assunzione di ulteriori impegni economici.
Dott. Gaspare Tesè
ContinuaCORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM L’IRROGAZIONE DI SANZIONI SIA TRIBUTARIE CHE PENALI, SCATURENTI DALLA STESSA VIOLAZIONE, QUALORA QUESTE SIANO STATE INFLITTE A DUE SOGGETTI SEPARATAMENTE.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con la sentenza del 5 aprile 2017 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze del 23 aprile e 23 giugno 2015 relativamente alle cause riunite C -217/15 e C -350/15, in tema di sanzioni tributarie e penali scaturenti dal mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
La questione è relativa al procedimento penale promosso nei confronti di un legale rappresentante di società, il quale ha omesso di versare entro i termini previsti dalla legge l’Imposta sul Valore Aggiunto che era dovuta sulla base della relativa dichiarazione annuale.
Tuttavia, prima che prendesse avvio il procedimento penale a carico del soggetto deputato al versamento della suddetta imposta, gli importi IVA dovuti dalla società legalmente rappresentata dall’imputato, sono stati oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale conseguentemente, oltre a liquidare il debito tributario, ha anche irrogato alla società una sanzione tributaria nella misura del 30% dell’importo dovuto.
Subito dopo l’irrogazione della sanzione, la società perveniva insieme all’Agenzia delle Entrate ad un accordo transattivo vertente sugli accertamenti dei periodi di imposta di cui alla dichiarazione IVA non versata, con il quale l’Agenzia delle Entrate rinunciando alla pretesa della sanzione, si accordava affinché la società pagasse la sola imposta dovuta. Pertanto, con la transazione, l’accertamento compiuto dall’amministrazione finanziaria relativamente alla dichiarazione annuale IVA non versata dalla società diveniva definitivo, atteso che lo stesso non è stato oggetto di impugnazione.
In seguito, l’Agenzia delle Entrate denunciava il reato di omesso versamento alla Procura della Repubblica, e veniva avviato un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per il reato di omesso versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, previsto dal combinato disposto degli artt. 10 bis e ter del decreto delegato n. 74/2000.
Conseguentemente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prendendo cognizione del procedimento avviato nei confronti del legale rappresentante, rilevava un manifesto contrasto tra la normativa prevista all’art. 10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, con il principio del c.d. ne bis idem.
Ed in particolare tale contrasto lo si rilevava in quella parte dell’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, che consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto, il quale sia già stato destinatario di un accertamento definitivo con relativa irrogazione di una sanzione amministrativa, con l’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in base ai quali nessuno può essere condannato penalmente per un reato per il quale sia già stato giudicato.
Pertanto, il Tribunale sollevava la questione pregiudiziale innanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha tuttavia rilevato e sottolineato che nel caso in esame le sanzioni tributarie sono state inflitte alla società, mentre il procedimento penale pendente era a carico di un soggetto diverso ovvero il legale rappresentante.
In tale circostanza, la Corte di Giustizia ha aderito alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale «il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie che sanzioni penali non costituisce una violazione dell’articolo 4 del protocollo n.7 alla CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente diverse» (Cfr. Corte EDU, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0520JUD00353211, § 51).
Infatti, i Giudici della Corte del Lussemburgo hanno definito la questione affermando che, il disposto dell’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e quindi del principio del c.d. ne bis in idem, non è in contrasto con la normativa nazionale che consente di avviare procedimenti penali per l’omesso versamento dell’IVA nei confronti di colui il quale, sia già stata irrogata una sanzione amministrativa/tributaria, allorquando tali sanzioni siano state inflitte a due soggetti giuridicamente diversi.
In conclusione, nel caso in esame, il Tribunale potrà legittimamente applicare la disciplina prevista dall’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, e pertanto, ne consegue che, nella fattispecie de qua non è applicabile il principio del c.d “bis de eadem re ne sit actio” comunemente conosciuto come “ne bis in idem”.
Dott. Gaspare Tesè
ContinuaLA “NUOVA” RESPONSABILITÀ MEDICA NELLA LEGGE N. 24 DEL 2017
La IV sezione penale della Corte di Cassazione, con la notizia di decisione n. 3 del 2017, nell’udienza del 20 aprile scorso ha chiarito che, in materia di responsabilità medica, ai fatti verificatisi prima del 1° aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Legge n. 24 del 2017), si dovrà applicare la vecchia e più favorevole previsione della c.d. legge Balduzzi, la n. 189 del 2012.
Quest’ultima infatti aveva escluso, all’articolo 3, comma 1, la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve, in tutte quelle situazioni nelle quali risultavano applicabili le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
In altre parole, con la nuova disciplina sulla colpa medica si sono “strette le maglie”, tanto da rendere applicabile un classico principio del diritto penale come il favor rei.
Si osserva che la Suprema Corte ha proceduto a un confronto tra le norme penali che si sono succedute nel tempo relative alla colpa medica.
Per i fatti anteriori alla legge 24 del 2017, potrà ancora applicarsi, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge 189/2012, la quale era sicuramente più favorevole; mentre per i fatti successivi a tale data si applicherà la nuova legge.
Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 16140 della medesima Sezione, possono così sintetizzarsi: «assume rilievo nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 4, Codice penale, secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole».
Invero, la legge n. 24 del 2017, all’art. 6, ha introdotto un nuovo articolo, l’art. 590 sexies, cod. pen., il quale prevede che se l’evento dannoso si è «verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
Tale nuova formulazione sembra lasciare margini di discrezionalità più ampi all’autorità giudiziaria rispetto alla situazione precedente. Starà infatti al giudice valutare, situazione per situazione, l’adeguatezza delle linee guida al caso concreto. Si è poi circoscritta la limitazione di responsabilità alle sole condotte rispettose delle linee guida caratterizzate da imperizia.
Quest’ultima soluzione palesa però un forte rischio: per effetto infatti di un confine assai esile tra le varie ipotesi di colpa, la pubblica accusa potrebbe puntare a trasformare casi di imperizia in imputazioni per negligenza e imprudenza. Ipotesi nelle quali non scatterà dunque l’esenzione per aderenza alle linee guida.
Secondo quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 28187, depositata lo scorso 7 giugno, la nuova disciplina non trova applicazione negli ambiti che per qualunque ragione non siano governati dalle linee guida; non trova neppure applicazione in quelle situazioni nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate. Peraltro, il novum non opera in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo (per esemplificazione si richiama il caso di un errore di esecuzione di un atto chirurgico: un chirurgo che esegue l’atto di asportazione di una neoplasia addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria con effetto letale).
Dunque, secondo la Corte di Cassazione sopracitata “il metro di valutazione costituito dalle raccomandazioni ufficiali è invece cogente, con il suo già indicato portato di determinatezza e prevedibilità, nell’ambito di condotte che nelle linee guida siano pertinente estrinsecazione”.
Inoltre, quelle situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o rese più difficoltose dall’urgenza implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione. In tale ambito ricostruttivo infatti può trovare applicazione, come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, il principio civilistico di cui all’art. 2236 c.c., il quale assegna rilevanza soltanto alla colpa grave.
Infine, altra novità prevista dalla legge 24/2017, è l’articolo 5, il quale ha ad oggetto un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
Dott.ssa Mariagrazia Broccia
ContinuaLA SUPREMA CORTE CASSA CON RINVIO LA SENTENZA DI CONDANNA, NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE VITTIMA DI ESTORSIONE, PER IL REATO DI MANCATO VERSAMENTO ALL’INPS DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.
La Corte d’Appello confermando la sentenza dei Giudici di primo grado, aveva condannato l’amministratore di una società per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti della società da lui amministrata, previsto dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463 del 1983.
Sin dal primo grado di giudizio l’imputato aveva invocato il diritto, previsto in favore dei soggetti vittime dei delitti di estorsione e usura, alla sospensione dei termini per il versamento, nelle casse degli enti previdenziali e assistenziali, delle somme dovute a titolo di ritenute, disciplinato dall’art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Invero, la Corte d’Appello ed il giudice di primo grado, avevano arbitrariamente denegato il diritto alla sospensione dei termini, nonostante l’imputato sia stato, in realtà vittima di estorsione, adducendo a motivazione che “la natura appropriativa”, della violazione dell’omesso versamento delle ritenute escluda la possibilità di beneficiare del diritto alla sospensione dei termini, prevista in favore delle vittime di usura ed estorsione.
L’imputato ricorrendo ai giudici di Piazza Cavour denunciava la mancata applicazione del beneficio della sospensione dei termini previsto in favore dei soggetti vittime di usura ed estorsione. La Suprema Corte accogliendo il ricorso ha ritenuto applicabile la norma di favore in quanto, tale norma non fa distinzione di species di debiti e pertanto anche i debiti previdenziali devono ritenersi ricompresi nella norma di favore prevista dall’art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello a causa dell’omessa applicazione del beneficio previsto in favore delle vittime di usura ed estorsione.
Dott. Gaspare Tesè
Continua